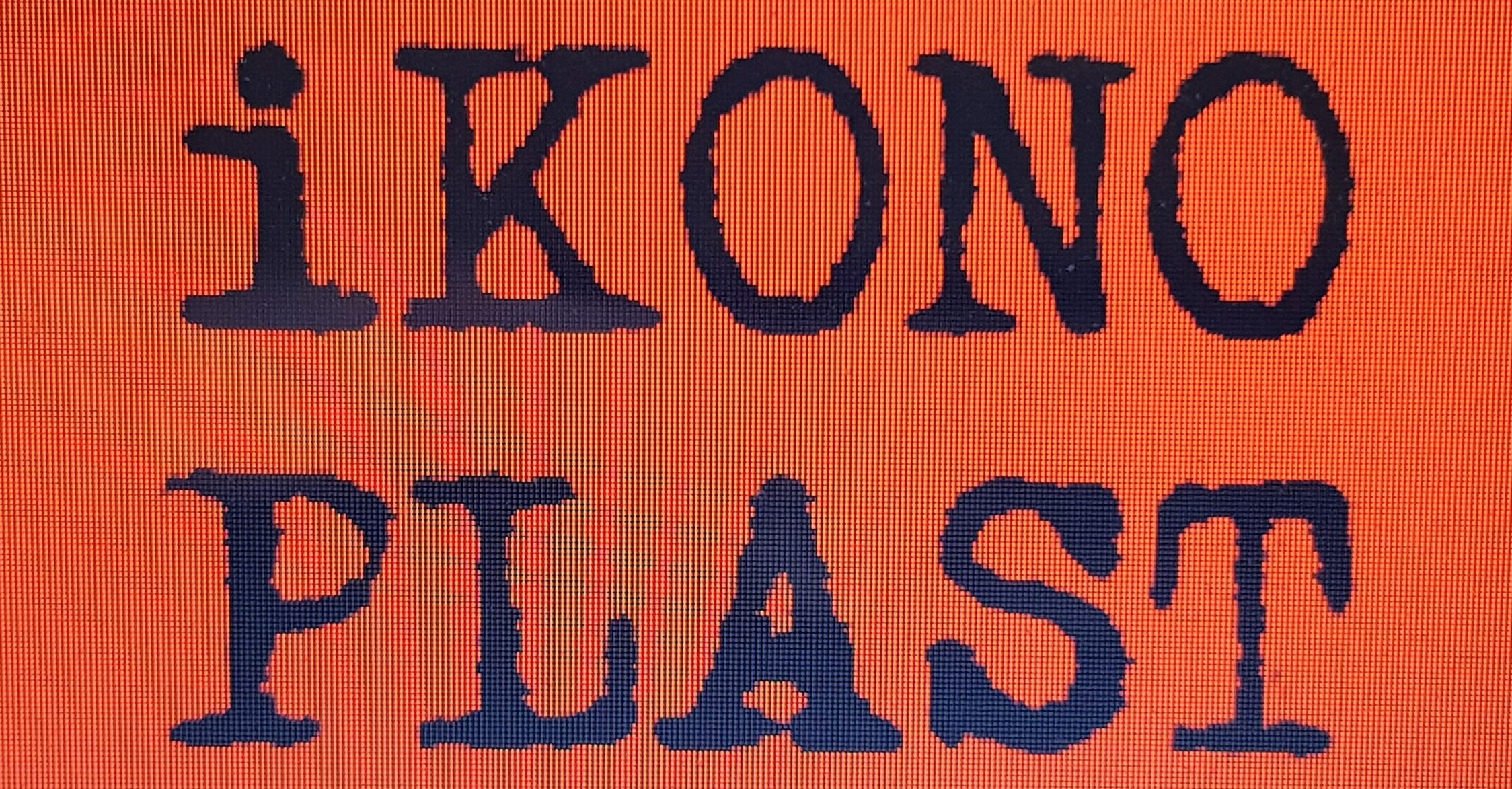«Cantami, o Diva, del pelide Achille l’ira funesta che infiniti addusse lutti agli Achei…”. Il proemio dell’Iliade introduce, proemio anch’esso, un cortometraggio che si dedica al dramma sociale e sanitario di un anno terribile come quello trascorso e, evidentemente, alla sua prosecuzione nefasta nei termini presenti. Il corto di 20 minuti, diretto da Andrea Dayan e scritto da Riccardo Loffredo, s’intitola sinteticamente 2020 e non lascia troppo spazio all’immaginazione nell’area dei suoi contenuti, tra le immagini che rimandano alle città deserte e all’incombenza di un virus sconosciuto nella struttura a metà strada fra narrazione teatrale e documento, con lampi surreali e interessanti intuizioni figurative.

Se le circostanze pandèmiche non fossero maledettamente reali sembrerebbe la traccia per un film di fantascienza apocalittica, sì insomma quel genere catastrofico che si è fatto largo con film come Contagion di Steven Soderbergh (è del 2011 e probabilmente il più profetico sulle dinamiche del Covid-19) o 28 giorni dopo di Danny Boyle del 2003 e via così, senza che sia necessario allungare una lista che in effetti è cospicua. Ovviamente proporzioni e contenuti sono differenti: perché qua l’intuizione extra-documentaristica rivisita la pandemia in cifra sociale, con le parole di un premier (“Da emergenza sanitaria a emergenza economica: ma lo Stato c’è”) che oggi, a distanza di tempo, sembrano proclami un po’ vuoti, non spalleggiati da certezze e risorse concrete.

Poi c’è l’aspetto speciale delle riprese, effettuate durante il lockdown utilizzando i cellulari degli attori: un sistema, se si vuole una necessità, che trasferisce comunque all’opera una immediatezza quasi di cronaca e di testimonianza – motivati nell’attenzione fotografica di Roberto Evangelista – pure nei suoi climi un po’ rarefatti e in certe soluzioni, a momenti, addirittura surreali. Come quella, legata appunto alle estetiche teatrali di un macerato monologo dove l’attore Marco Di Stefano recita il personaggio del lavoratore sempre più stremato, con l’andare delle cose, nel suo flebile soffio vitale, appeso ad un contratto giornaliero che lo costringe a soffiare in un salvagente bucato, vittima oramai conclamata della “pandemia del lavoro precario” (reclamata da Fabio Sartor davanti all’obbiettivo) generatrice di una folla anonima e invisibile. Con il simbolo, grottesco e provocatorio insieme, di quel benefit aziendale quale “la pistola da usare quando non avremo più bisogno di te”.